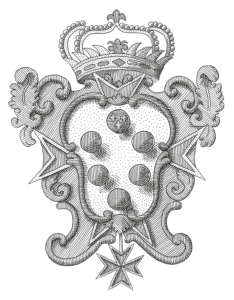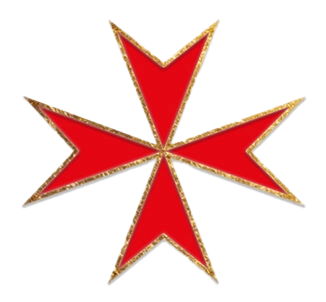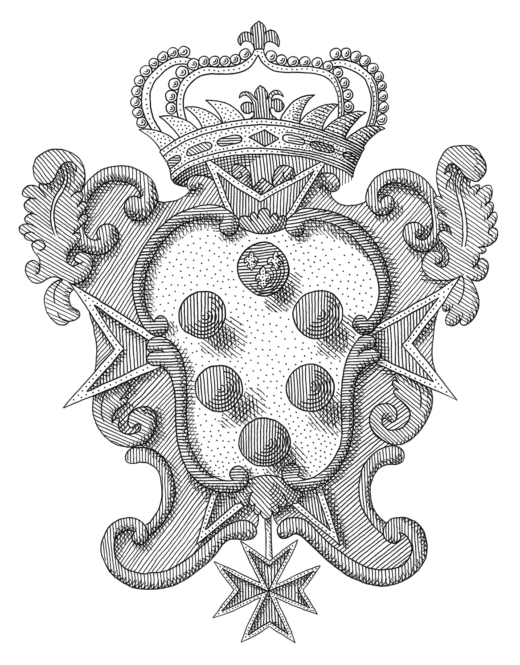di Francisco Acedo Fernández
Auditore della Deputazione Granducale per la Nobiltà e la Cittadinanza
Il nome dei Medici evoca un’aura di fascino, rispetto e ammirazione come pochi altri. La famiglia ebbe origine nella zona del Mugello, più precisamente a San Piero a Sieve, dove tra la fine dell’XI e l’inizio del XII secolo un certo “Medico”, castellano di Potrone per conto della potente famiglia degli Ubaldini, è il primo personaggio documentato della stirpe da cui deriva il cognome patronimico “Medici”. Le prime generazioni si dedicarono al commercio, alla manifattura della lana e, in minor misura, alla banca e alla politica. Uno dei primi a ricoprire cariche pubbliche nella Repubblica Fiorentina fu Salvestro di Alamanno de’ Medici, che fu gonfaloniere. Inquadrato nella fazione guelfa, come l’intera famiglia, pur essendo di origini patrizie, si presentò come portavoce dei settori popolari e nel 1378 sostenne la rivolta dei Ciompi guidata da Michele di Lando contro l’oligarchia cittadina.
La vera ascesa della famiglia avvenne tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo con Giovanni di Bicci de’ Medici, fondatore del Banco Medici, che divenne banchiere dei Papi e finanziò Francesco Sforza nella conquista di Milano ed Edoardo IV d’Inghilterra, vincitore della Guerra delle Due Rose. Suo figlio, Cosimo il Vecchio, capostipite del ramo dei Medici di Cafaggiolo, fu il primo a controllare la Repubblica Fiorentina, basando il proprio potere sul sostegno popolare che vedeva nei Medici dei governanti tolleranti, in contrasto con l’oligarchia aristocratica. Con lui iniziò anche il mecenatismo delle arti, delle lettere e del pensiero. Cosimo il Vecchio fondò l’Accademia Neoplatonica, germoglio del pensiero umanistico che si oppose all’aristotelismo scolastico e diede origine al Rinascimento. Senza i Medici e il loro mecenatismo, non si può comprendere il Rinascimento, uno dei momenti culturali più alti della storia dell’Occidente, paragonabile solo all’Atene di Pericle o all’Alessandria dei Tolomei. A differenza di altre casate come gli Asburgo, i Borbone, i Romanov o i Windsor, i Medici non possedettero grandi imperi, ma la loro influenza sul destino dell’Europa e del mondo fu enorme grazie all’impulso dato alle nuove idee che, nel XV secolo, fecero rinascere la migliore visione dell’antichità classica, cambiando per sempre la mentalità collettiva attraverso la concezione dell’Umanesimo Cristiano.
I grandi nomi della dinastia sono incisi per sempre nei luoghi d’onore della storia: Lorenzo il Magnifico, Alessandro primo Duca di Firenze, Cosimo primo Granduca di Toscana; i Papi della famiglia Leone X, Clemente VII e Leone XI; le regine di Francia Caterina e Maria, e numerosi personaggi che ricoprirono alte cariche militari, politiche ed ecclesiastiche in Toscana e oltre, tra cui otto cardinali. La grandezza della famiglia si fondò sulla potenza economica derivata dalla banca, sul sostegno del popolo fiorentino, sull’ascendente presso il papato e sull’appoggio imperiale. Nel 1530 Carlo V riconobbe Alessandro de’ Medici come Signore di Firenze, sciogliendo così la Repubblica, e nel 1532 lo nominò Duca di Firenze. Il suo successore, Cosimo I, fu creato Granduca di Toscana nel 1569 per Bolla di Papa Pio V, dopo la conquista della Repubblica di Siena. Massimiliano II confermò la dignità granducale con un editto nel 1576. I suoi successori regnarono in Toscana fino alla complessa successione di Gian Gastone, ultimo Granduca della linea di Cafaggiolo.
Nel 1711, dopo la morte improvvisa e senza eredi del Principe di Toscana Francesco Maria de’ Medici, avvenuta il 3 febbraio, il Granduca Cosimo III era consapevole che non ci sarebbe stato alcun discendente diretto del suo sangue. Volendo rispettare l’ordine di successione stabilito dalla Bolla Imperiale di Carlo V del 1532, dalla Bolla papale di Pio V del 1569 e dall’Editto Imperiale di Massimiliano II del 1576 — che prevedevano, in assenza di un erede diretto, la successione del parente più prossimo, a prescindere dal grado di parentela, purché appartenente alla famiglia Medici — il Granduca proclamò Principe di Toscana e futuro successore del Granducato il suo lontano cugino Giuseppe de’ Medici di Toscana, Principe di Ottajano. Il titolo di Principe di Toscana è chiaramente indicato anche nell’atto imperiale di nomina dello stesso Giuseppe de’ Medici di Toscana a plenipotenziario cesareo per la consegna della Sardegna ai Savoia, conferito dall’Imperatore Carlo VI a Lussemburgo il 12 giugno 1720 e conservato negli archivi della corte reale e in quelli storici di Cagliari.
A conferma di tale nomina vi è la testimonianza dell’ambasciatore di Francia in Toscana, il Conte de Gergy, che ne riferì alla corte francese, annotandolo nella corrispondenza diplomatica dell’epoca, oggi conservata presso il Ministero degli Affari Esteri francese.
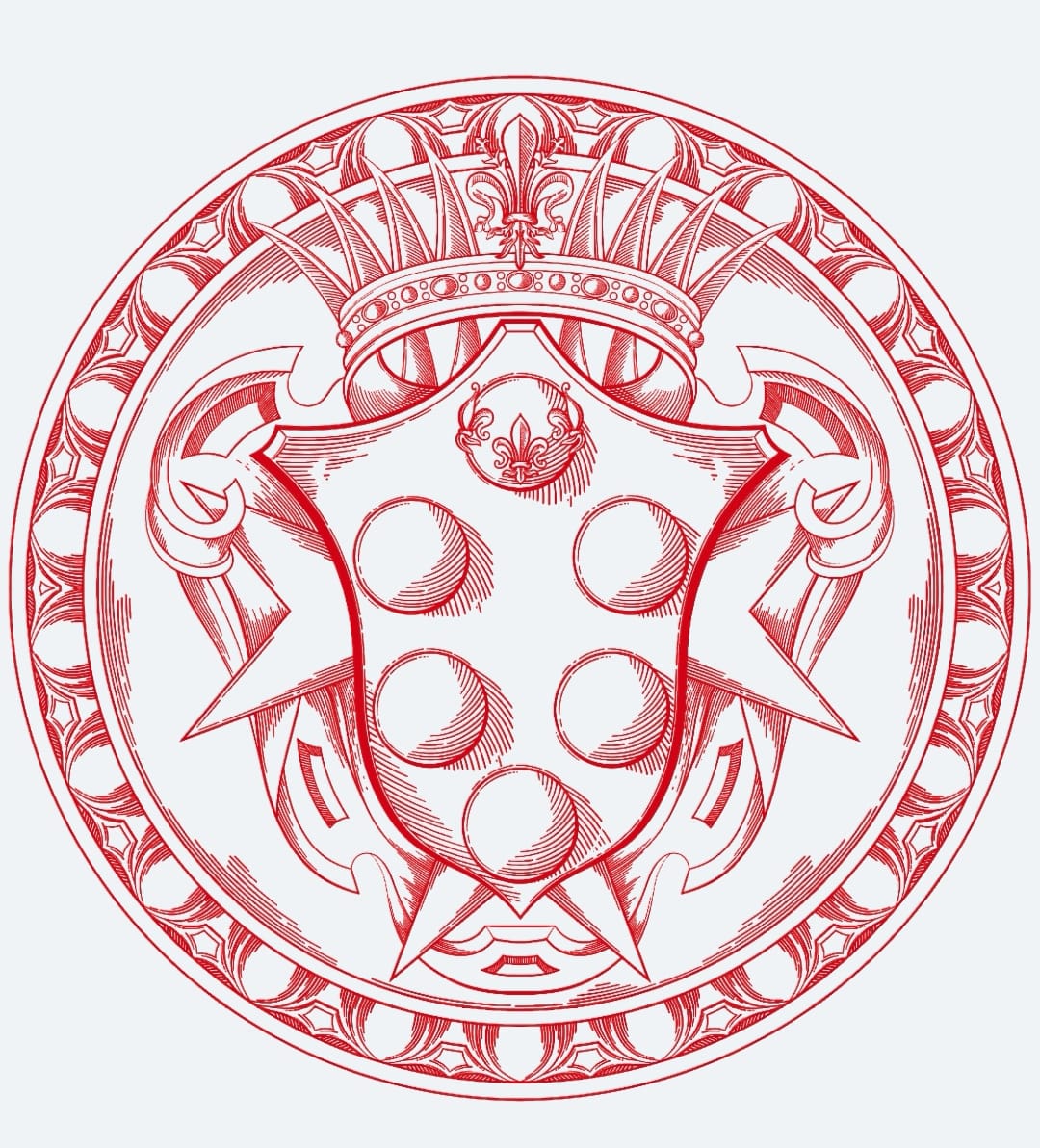
La decisione del Granduca incontrò tuttavia l’opposizione di una parte dell’élite fiorentina, decisa a restaurare i vecchi ordinamenti repubblicani. Essi, adducendo ragioni false e pretestuose, spinsero il Granduca a far sì che sua figlia Anna Maria Luisa de’ Medici, Elettrice Palatina, venisse designata dal Senato come possibile erede del Granducato. La scelta fu strategica: Anna Maria Luisa era sterile e priva di discendenza, e si pensava che alla sua morte la Toscana sarebbe potuta tornare ad essere una repubblica, libera dal vincolo dinastico dei Medici.
Con questa designazione, Cosimo III violava le disposizioni ereditarie sancite dalla Bolla Imperiale di Carlo V del 1532, ben conosciute da tutte le potenze europee, che stabilivano che, in caso di estinzione della linea di Cafaggiolo, il Ducato di Firenze sarebbe dovuto passare in infinito al parente più prossimo della famiglia Medici, indipendentemente dal grado di parentela rispetto alla persona inizialmente investita del titolo ducale. Tale linea successoria fu poi confermata anche dalla Bolla Papale del 27 agosto 1569 concessa da Papa Pio V a Cosimo I per l’erezione del titolo granducale, e dalla successiva Bolla Imperiale che lo riconfermava a Francesco I de’ Medici da parte dell’Imperatore Massimiliano II.
Secondo le condizioni di pace stabilite tra l’Imperatore Carlo V e la Repubblica di Firenze, una violazione di tali disposizioni avrebbe comportato per Firenze la perdita di tutta la libertà conquistata fino a quel momento, lasciando all’Imperatore la possibilità di disporre liberamente dello Stato toscano. E così avvenne: a partire dal 1720 la Toscana fu considerata dall’Imperatore una moneta di scambio utile per stipulare accordi internazionali favorevoli al Sacro Romano Impero.
Al termine di negoziazioni internazionali durate quindici anni, le potenze decisero che la Toscana sarebbe stata assegnata alla Casa d’Asburgo-Lorena. Per ufficializzare il passaggio, l’Imperatore Carlo VI, nel 1736, emanò un nuovo decreto di investitura granducale a favore della famiglia di Lorena, sostituendo così l’investitura precedente concessa nel 1576 da Massimiliano II a Francesco I de’ Medici e ai suoi successori legittimi e agnati (o collaterali maschi). Questa nuova investitura di Francesco Stefano di Lorena come Granduca di Toscana da parte di suo suocero l’Imperatore Carlo VI, fu fatta per compensare la perdita del Ducato di Lorena nella recente Guerra di Successione Polacca.
Tuttavia, secondo il diritto canonico, l’Imperatore Carlo VI non poteva abrogare la Bolla Papale del 1569 emanata da Pio V, la quale investiva Cosimo I de’ Medici e i suoi discendenti — o, in mancanza, i collaterali maschi — del titolo di Granduca di Toscana.
Pertanto, nel 1737, alla morte del Granduca Gian Gastone, ultimo esponente maschile della linea medicea di Cafaggiolo, Giuseppe de’ Medici di Toscana, Principe di Ottajano, assunse per sé e i propri discendenti il titolo di Granduca titolare di Toscana, in virtù della Bolla Imperiale del 1532 e della Bolla Papale del 1569, tuttora valida. I suoi discendenti hanno portato avanti la rivendicazione dinastica fino ad oggi, facendo uso pubblico del titolo di Principi e Granduchi di Toscana, stabilendo generazione dopo generazione relazioni di alto livello con le Case Reali dei Borbone di Napoli e dei Savoia, e accettando incarichi governativi rilevanti da parte di tali sovrani, nella speranza che, un giorno, potessero ottenere, per vie diplomatiche, nuovamente il governo della Toscana o di altri territori. Nei documenti ufficiali del Regno delle Due Sicilie sono sempre indicati come “Medici di Toscana”.
Nel 1737, le potenze europee, con il sostegno dell’oligarchia aristocratica fiorentina, imposero Francesco Stefano di Lorena come Granduca di Toscana — contro ogni diritto, come abbiamo visto — e i suoi discendenti, gli arciduchi austriaci, occuparono il trono dei Medici fino al 1859. Il 27 aprile di quell’anno, con lo scoppio della Seconda Guerra di Indipendenza tra l’Austria e il Regno di Sardegna, la famiglia Asburgo-Lorena abbandonò Firenze e si rifugiò presso la corte imperiale di Vienna, ponendo fine a centoventidue anni di occupazione straniera.
Il 20 dicembre 1866, il ramo toscano degli Asburgo-Lorena cessò ufficialmente di esistere, tornando a essere parte della Casa Imperiale d’Austria. Per ratificare ciò, nel 1870 Ferdinando IV di Asburgo-Lorena abdicò formalmente ai suoi diritti di pretendente al Granducato di Toscana a favore dell’Imperatore Francesco Giuseppe I. Da quel momento, agli arciduchi discendenti di Leopoldo II fu proibito l’uso di titoli toscani, e lo stesso Imperatore assunse il titolo di Granduca di Toscana, in virtù dell’abdicazione di Ferdinando IV per sé e per i propri discendenti.
⸻

Gran Duca Ottaviano de’ Medici
Il Gran Duca Ottaviano de’ Medici di Toscana ha proseguito le rivendicazioni dei suoi antenati ed è l’erede legittimo e titolare del Granducato di Toscana, in virtù della Bolla Papale di Pio V del 1569, che stabiliva la successione ereditaria del Granducato in favore dei discendenti agnati di Cosimo I, e in mancanza di questi, al ramo collaterale più prossimo — che è sempre stato quello dei Principi di Ottajano.
Per le stesse ragioni, è Gran Maestro dell’Ordine di Santo Stefano, in virtù della Bolla Papale di Pio IV, ma di questo si parlerà in un prossimo articolo.
Padre di tre figli, risiede a Firenze, come i suoi antenati, e mantiene vive le tradizioni della sua Casa, alla quale ha dedicato anche un volume molto interessante. Autore del Manifesto del Nuovo Umanesimo Mediceo, fonda il proprio pensiero su cinque pilastri: Bellezza, Nobiltà, Libertà, Umanità e Ragione. Tra le sue principali preoccupazioni vi sono l’ambiente, la sostenibilità e il dialogo tra i popoli attraverso la cultura. Un uomo del Rinascimento nel pieno del XXI secolo.
Per saperne di più: www.de-medici.com
Contatto: francisco.acedo.fernandez@de-medici.com